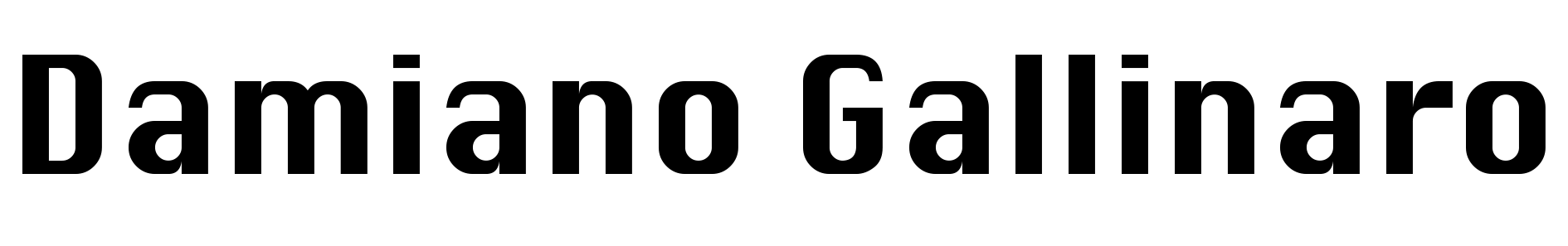La ex Jugoslavia, Srebrenica e soprattutto il dramma delle donne violate e dei figli “bastardi” nati da quelle violenze, emergono con forza e delicatezza al tempo stesso in questa storia che ho scritto qualche anno fa ma che ha avuto la sua scrittura definitiva solo dopo l’incontro con Bakira e altre donne di Visegrad che questa terribile violenza hanno subito e di cui portano ancora i segni non solo nel corpo ma soprattutto nell’anima. Nel silenzio di Mirijana c’è l’impossibilità di molte di queste donne di raccontare quanto di terrificante hanno subito. Ma c’è sempre speranza e la speranza è negli occhi e nella forza di una bimba innocente venuta al mondo nel peggiore dei modi ma che con il suo solo essere al mondo assume le sembianze della speranza. La storia di Mirijana è comunque una storia di resilienza e speranza.”
A Bakira Hasecic
La ragazza raccoglie la legna e la ordina con pazienza. Il fumo del camino sale nel cielo e si confonde con il fumo acre e biancastro delle acciaierie. Un altro inverno freddo sta per iniziare nella Città del Sale e la ragazza alza gli occhi verso la montagna ripensando ai giorni terribili passati nella Città dell’Argento più di dieci anni prima.
Una bambina con i capelli crespi fa capolino dalla porta di casa, la donna la guarda, le sorride e il suo è un sorriso al tempo stesso dolce e amaro, come la tua terra. La saluta mentre va via, con un tenero bacio sulla fronte.
Pela le patate e le mette in una pentola per farle bollire, prepara poi della verdura per la minestra. La bambina è a scuola e così lei è sola con il suo silenzio. Passa qualcuno per strada, lei saluta dalla finestra, questa città, pensa, è ancora un posto in cui si può vivere, un luogo da cui ricominciare. Ma la notte è piena di incubi, quelli che nascono da quel posto in cui ci si rifugia quando siamo bambini, quel bambino dentro che ora è stato violato e che urla nel buio dell’incubo.
La ragazza attraversa la strada statale che separa il piccolo quartiere collinare dove vive, dal centro della città del Sale, le macchine sfrecciano veloci, e il fumo delle fabbriche si confonde ancora una volta con il cielo grigio. Non sarebbe mai voluta uscire soprattutto perché è uno di quei giorni in cui tutto sembra così vivido, così terribilmente presente. Attraversa con calma la via pedonale che porta alla piazza principale, saluta distrattamente alcune donne sedute sull’uscio di casa e si avvia verso un piccolo vicolo laterale.
C’è un mare di ricordi nel cuore della ragazza che piange lacrime silenziose mentre sfrega le scale del palazzo signorile dove lavora. I ricordi, pensa, quasi sempre ti scavano dentro soprattutto quando non sono facili da mandare via. Quel giorno in cui tutto avvenne lei aveva iniziato la giornata come sempre, una tazza di caffè turco con un lokum, pitta al formaggio e un cucchiaio di yogurt kefir. Poi, in cerca di un’improbabile normalità, era andata a passeggiare, aveva guardato la montagna che già da tempo non era più la montagna felice dell’infanzia, nessuno era davvero pronto a quello che sarebbe accaduto, nessuno, neppure quelli che avrebbero dovuto salvarla… salvarli.
Non ce la fa più a continuare, deve cercare di ricacciare dentro il magone, l’angoscia, tra un po’ la signora passerà a salutarla e come sempre le passerà la mano sul capo con un affetto che non ha mai compreso, ma che le riempie l’anima, e non si può che donare un sorriso a chi ti dona amore, anche se nel cuore l’amore è finito da tempo, celato dalle ombre.
E così, la mano della donna sfiora il capo della ragazza, ha delle uova fresche per la sua bambina, le dice. La ragazza sorride alla signora che a sua volta sorride stanca, neanche con lei la vita è stata buona, anche se ha dovuto soffrire un dolore diverso. La sua, riflette la ragazza, è una terra di dolore, una terra di infinite ed interminabili tragedie, ma da cui il suo popolo si è sempre rialzato. Le tragedie di un popolo sono le tragedie di singole persone che sommate fanno la terribile tragedia della storia, così affermava un suo professore al liceo.
La ragazza guarda l’orologio è già mezzogiorno, è tempo di andare. Al mercato compra delle rape e della carne, il latte e qualche piccolo dolce per la sua bambina. Mentre aspetta che il semaforo diventi rosso per attraversare la strada, un ragazzo la nota e le fischia, lei vorrebbe ridere di quel complimento sgraziato, ma piange lacrime trattenute e il suo corpo si scuote e trema nel ricordare cosa non potrà più essere, cosa non potrà più donare.
Torna a casa e all’improvviso sente di non avere più forze, succede sempre così quando il passato ritorna. E il passato ritorna sempre purtroppo, è quello il problema. Guarda fuori dalla porta, c’è un uomo con i fiori in mano che la guarda, si toglie il cappello e la saluta. Come ogni mese quest’uomo, che si reca al mercato per vendere i prodotti del suo piccolo orto, le porta dei fiori e in silenzio aspetta di essere ricevuto. Sempre in silenzio lei lo invita a entrare, lo fa sedere a tavola, prende i fiori e li mette in un vaso, poi prepara il caffè lungo e speziato come piace agli uomini della sua terra. Lo bevono insieme guardandosi negli occhi. L’uomo è innamorato di lei da quando l’ha vista al mercato ormai un anno fa. Prima di andare via l’uomo le sfiora il braccio nudo, vorrebbe tanto provare quel brivido che neppure molti anni fa le provocava la carezza di un ragazzo, invece anche stavolta non prova nulla, abbassa gli occhi. Da all’uomo del pane e una torta fatta in casa. Ci sono cose che lei non può più donare, non può più donarsi. Così l’uomo va via, chiude la porta dietro di se e riprende il cammino di ritorno verso il suo villaggio. Lei piange scuotendosi tutta, mentre pensa con orrore che la sua vita si è fermata ad un giorno di luglio di qualche anno prima e da allora non è più ripartita.
La sera davanti alla luce della TV, le immagini di un altra guerra, di un altro dolore, vorrebbe urlare ma non ce la fa, le parole sono chiuse, trattenute nel cuore.
Al mattino la figlia la guarda e le chiede ancora una volta “Mamma ma perché non parli più?”. La bimba è sicura di aver sentito la sua voce quando era piccola, quando le raccontava le ninne nanna. La bimba guarda la ragazza come solo le bimbe sanno fare e Mjriana piange, l’abbraccia e sussurra qualcosa d’incomprensibile all’orecchio della bimba.
I giorni passano uguali tra ricordi che non riescono ad andare via e una vita da trascinare avanti fino a che un giorno la ragazza riceve una lettera. Guarda e riguarda la busta, la gira e la rigira ma non riesce ad aprirla, ha quasi paura di sapere cosa contenga. La vita è stata crudele con lei e può esserlo fino in fondo. E’ una vittima di guerra, lei e la figlia lo sono, e spetta loro una forma di risarcimento, se mai si può risarcire la perdita della felicità, dell’innocenza.
Apre la busta quasi guardando da un’altra parte, poi legge le poche righe: “La S.V. è inviata a presentarsi presso la sede del Tribunale Supremo di Sarajevo per comunicazioni riguardanti la pratica n… da lei presentata in data…”. Poche righe in burocratese per non dire nulla e lasciare in sospeso tutto.
Dalla Città del Sale, la sua Tuzla, dovrà andare di nuovo verso la Capitale di uno stato che non esiste e di cui stenta a sentirsi parte. Tra poche ore la sua bambina tornerà da scuola, dovrà farle capire che tra qualche giorno la mamma si assenterà per qualche ora, forse un’intera giornata e non è mai accaduto finora, mai ha lasciato sola la figlia.
Ma la bimba è forte, molto più di lei, quei suoi occhi, da bastarda di questo paese bastardo, sono sempre duri come la pietra. Portano il segno della violenza, ma in alcuni giorni anche il fuoco della speranza.
Come il fuoco nel camino che crepita, in questa sera d’inverno che ne ricorda un’altra in cui, si racconta, l’Orso di Tuzla ha abbandonato il bosco, ha rotto degli steccati.
La lettera ha riaperto ulteriori ferite mai completamente rimarginate. La ferita più grande non è quella che emerge in fondo al cuore, no la ferita più grande è quella che ragazza sente tra le sue gambe, quella ferita che ancora oggi emerge al ricordo di quello che è successo quel giorno nella Città dell’Argento. Ogni volta il dolore fisico è insopportabile e ogni volta le sembra che il suo corpo la rifiuti.
Era successo tutto in fretta, le avevano separate dagli uomini come facevano i nazisti nei campi di concentramento di cui aveva sentito parlare a scuola.
Le avevano sbattute a terra e poi una per una erano state scelte da un uomo che strattonandole le aveva portate via. Le vecchie, le nonne, il patrimonio di storie di vita di questo piccolo paese, costrette a guardare, separate dalle figlie dalle nipoti, costrette a subire l’oltraggio che sempre porta la guerra.
E’ il sesso che muove il mondo e che muove la guerra, lei ne era certa da sempre.
Ogni soldato sogna di avere una donna in guerra, anche quell’olandese che la guardava ogni giorno e a cui aveva sorriso e che le aveva regalato quella sua foto con il nome e cognome dietro, cosa poteva volere di più? Eppure le era sembrato diverso, dolce, gentile, ma dov’era quel giorno, perché non aveva fatto nulla? E perché lei comunque continuava a conservare quella foto?
Forse non poteva sparare, ma almeno poteva gridare, farle capire che avrebbe fatto qualcosa per lei, per le altre. Forse sarebbe bastato, ma chissà dov’era rimasto, lì, fermo, come un soldatino di stagno guardando un uomo che fino a qualche tempo prima la ragazza avrebbe chiamato fratello e che l’aveva trascinata dentro quella casa di legno e pietra. Cos’era successo dopo? La ragazza guarda fuori verso i monti e sospira, lo ha raccontato più volte nelle deposizioni e ricordarlo riapre ancora quella ferita, quella fitta che è impossibile da sopportare.
Alcune immagini le tornano alla mente con più forza di altre: un uomo che la spinge verso la staccionata e la blocca contro il legno passandole le mani con forza sul corpo, strappandole la t-shirt mentre la tiene stretta con le gambe possenti. Ancora adesso le manca il fiato, non riesce ad andare avanti nel ricordo. Ricorda di aver provato a gridare ma l’uomo l’aveva minacciata puntandole la pistola in fronte, mentre premeva sempre di più contro di lei.
Ad un certo punto era riuscito a superare ogni sua debole difesa e aveva posto in essere quello che altro non era che l’ennesimo atto di guerra, come se quella liberazione finale nel suo corpo di adolescente non fosse altro che l’ennesima mitragliata scagliata contro la gente di Bosnia.
Terminato l’atto di guerra, l’uomo aveva addirittura cercato un bacio da parte della ragazza che si era divincolata e aveva cercato di scappare. Ricorda ancora perfettamente le parole di quell’essere sussurrate con rabbia e disprezzo: “Piccola puttanella musulmana porterai sempre con te il ricordo di questa guerra, di questa nostra vittoria, il figlio bastardo di una nazione bastarda che chiamavamo Jugoslavia”. Poi le aveva sputato in faccia e l’aveva buttata con forza per terra.
Di quello che è successo dopo la ragazza ricorda poco, ricorda di essersi rannicchiata in posizione fetale quasi sperando che qualcuno le sparasse, poi altre ragazze gettate in quella che sarebbe divenuta una trappola. Quando aveva sentito il fumo aveva urlato cercando di scuoterle, ma invano. Riuscì a farsi spazio tra due assi divelte, non ricorda come, poi la mano di qualcuno l’aveva tirata fuori e successivamente trascinata verso il bosco. Ancora adesso non sapeva se chi l’avesse salvata fosse un uomo, una donna, un amico o un nemico.
In qualche modo era viva, se si poteva quella considerare vita.
La ragazza guarda il fuoco crepitare, la bambina fa i compiti e guarda fuori dalla finestra, da ore cerca di riprendere fiato, rivivere tutto le ha fatto come sempre malissimo.
Fa freddo, nel pomeriggio è passata a trovare una sua vicina, le ha spiegato a gesti che deve andare a Sarajevo, le ha mostrato la lettera, e le ha chiesto di badare alla piccola Malina. Si è sforzata di parlare, ma le parole quasi non si udivano, ma dovrà trovare la forza di parlare a Sarajevo.
Il mattino seguente la nebbia copre tutta la valle come accade spesso nel lungo inverno bosniaco, carezza il capo della bambina e poi si dirige verso la finestra. Le manca la sua città, la città dell’Argento, Srebrenica. Srebro, infatti, significa argento nella sua lingua, che è poi anche la stessa dei suoi aguzzini. Le manca, nonostante tutto, ma non è più riuscita a tornarci, anche perché non ha morti da piangere, non sa dove siano i corpi dei suoi cari.
Chiude i pugni e si avvia verso la strada principale, nelle tasche frammenti di sale e argento.
Il racconto ha partecipato al Contest Sguardo ad Est